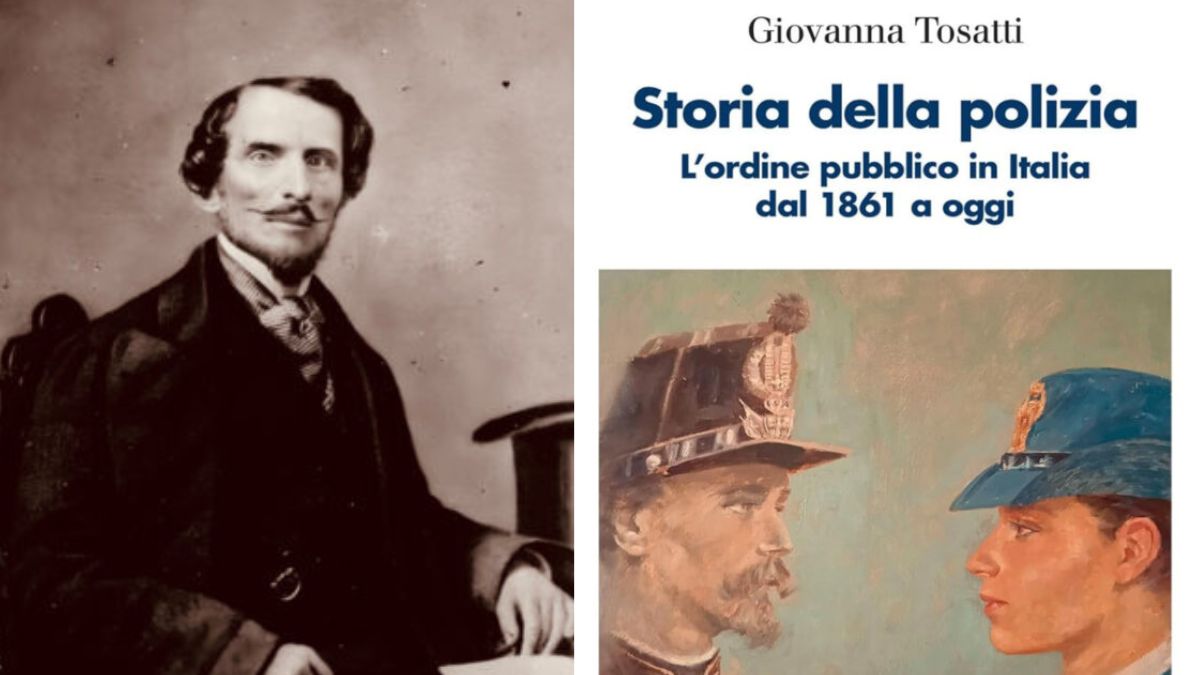
Presidente del Consiglio e ministro dell’Interno il “barone di ferro” Bettino Ricasoli emanò nel 1867 le prime istruzioni per i funzionari della polizia. Il funzionario – scrisse – deve essere “cauto e riservato nella relazione del suo Uffizio, vigile protettore della libertà dei cittadini, generoso co’ deboli e severo co’ prepotenti, pieno del sentimento della forza della legge, di cui è chiamato a mantenere l’osservanza, primo a comparire in occasioni di pubbliche sventure, sagace esploratore de’ bisogni delle popolazioni”.
Il Regno d’Italia era nato appena sei anni prima, e per la presa di Roma mancavano ancora quattro anni. Tra i mille problemi che l’Italia doveva affrontare con l’annessione degli Stati preunitari, quello della gestione dell’ordine pubblico non era certo secondario. Si trattava di creare un modello nuovo, “nazionale”, capace si subentrare a quelli precedenti, molto diversi tra loro. Per i Carabinieri e la Guardia di Finanza fu relativamente più facile. Per la polizia fu invece molto complicato. Tra i sistemi del Lombardo-Veneto, di matrice austro-ungarica, e quelli del Regno di Napoli le differenze erano macroscopiche, per l’inquadramento, per le caratteristiche del personale, per le funzioni.
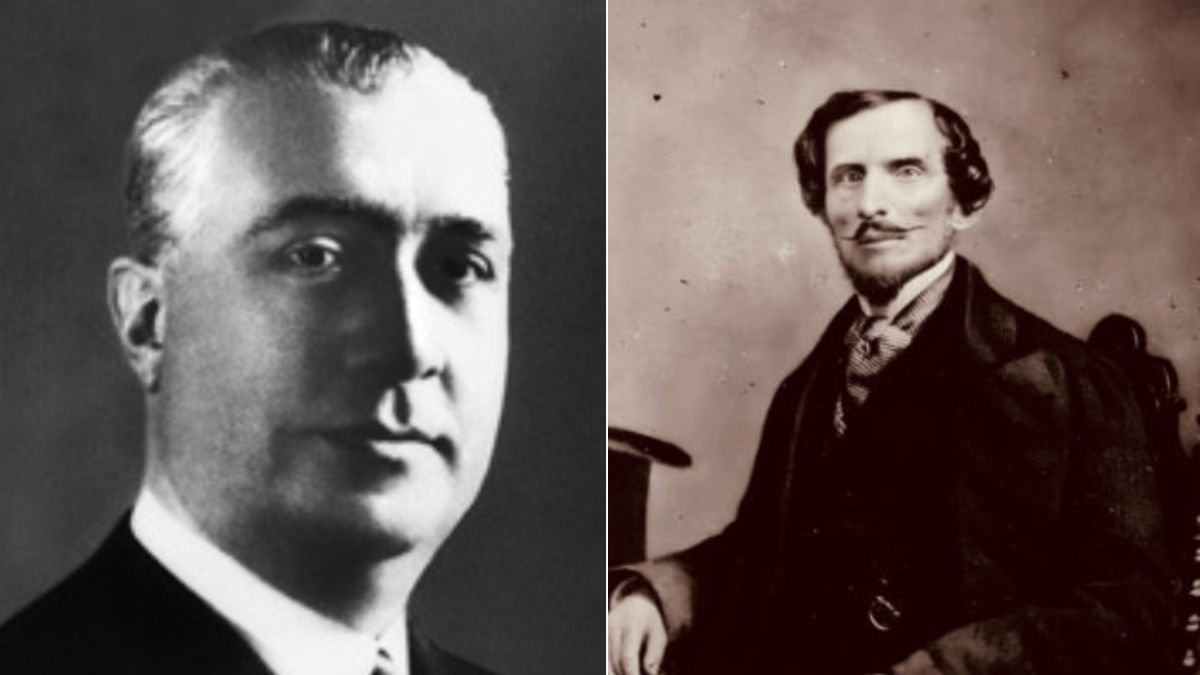
Dunque – come ricostruisce Giovanna Tosatti in un saggio ben documentato – la storia della polizia italiana è stata molto complessa, caratterizzata dal mutare delle scelte politiche che si sono alternate durante l’Italia liberale, governata dalla sinistra e della destra storica, negli anni giolittiani, nel ventennio fascista, nel periodo della transizione alla Repubblica democratica, e anche nelle varie fasi che hanno segnato l’intero dopoguerra, fino ai nostri giorni.
Giovanna Tosatti è una storica della pubblica amministrazione. Ma sbaglierebbe chi affrontasse la lettura del suo lavoro – Storia della polizia. L’ordine pubblico in Italia dal 1861 a oggi, (Il Mulino) – solo come se fosse un testo specialistico. Certamente lo è, ma fin dalle prime pagine si comprende di avere in mano una storia dell’Italia, non solo della polizia. È, in effetti, una storia globale della Nazione, dell’evoluzione della sua cultura politica, del rapporto tra i cittadini e lo Stato, del ruolo dei pubblici dipendenti svolgono, al di là delle svolte politiche, nel garantire la continuità del servizio al quale solo chiamati.
Nel caso della pubblica sicurezza, si trattava fin dal 1861 di scegliere un modello, che finì con l’essere intermedio tra quello britannico e quello francese napoleonico. Le “istruzioni” di Bettino Ricasoli fanno riferimento soprattutto alla polizia londinese, armata solo di manganello, percepita come amica del cittadino, comprensiva dei suoi bisogni, pronta ad aiutarlo. Il poliziotto come “amico” e non come “sbirro”.

I cambiamenti nel corpo di polizia nella storia italiana
Col tempo, naturalmente, la polizia ha assunto compiti sempre più definiti. Tra i primi poliziotti era facile trovare analfabeti. Poi nacquero le scuole, i sistemi informativi, gli archivi dei delinquenti. Gli agenti sono cresciuti di numero, di cultura, di capacità ed efficienza, sempre con l’obiettivo di proteggere i cittadini e di contrastare i malviventi e la criminalità organizzata.
Tosatti non manca in questo lungo percorso di segnalare luci e ombre, che riguardano certo la polizia, ma non possono essere isolate e disgiunte dalla storia della nazione. Questa narrazione – sottolinea – comprende <l’esempio virtuoso della comunità di uomini (e ora sempre più donne) che hanno interpretato da protagonisti (in alto come in basso) quella storia, la constatazione della loro abnegazione, della loro capacità di sacrificio, della loro onestà, e al tempo stesso le pagine negative di qualche tradimento persino del giuramento prestato allo Stato>.
Polizia e ventennio fascista: il ruolo di Bocchini
Nella sua complessità Storia della polizia spinge il lettore a riflettere anche su momenti particolari del nostro passato. Nel ventennio fascista, per esempio, stupisce che al vertice della polizia il prefetto Arturo Bocchini sia rimasto in carica per un per un periodo lunghissimo, dal 1926 fino alla morte nel 1940. Curiosa eccezione, perché Mussolini cambiava rapidamente ministri e soprattutto sottosegretari. Si spiega in realtà con la sua capacità proteggere il duce dagli attentati, che furono pochissimi rispetto – per esempio – ai numerosissimi contro Hitler. Il sistema di prevenzione in quell’Italia funzionava, grazie all’efficienza della polizia politica e dell’Ovra, che ovviamente hanno svolto ruoli non commendevoli contro la dissidenza antifascista.
Crollato il regime, Badoglio militarizzò la polizia. Nulla cambiò con i primi governi democratici. D’accordo erano Bonomi, Parri, De Gasperi. Per tornare alla polizia civile si deve attendere la riforma del 1981. E anche l’Italia repubblicana e democratica ebbe il suo Bocchini. Il prefetto Angelo Vicari fu in carica dal 1960 al 1973. Anche in questo caso, mentre i governi di centrosinistra duravano poco, Vicari resisteva perché era un bravo dirigente al servizio dello Stato.
Dettagli, certo. Ma il lavoro di Giovanna Tosatti, tra un dettaglio e l’altro, ci aiuta a capire 164 anni della nostra storia. E anche a guardare con più simpatia chi ha scelto di servire lo Stato, e noi cittadini, come vigile protettore della nostra libertà.


