
Il 20 aprile 1999 due studenti della Columbine High School, Eric Harris e Dylan Klebold, entrarono a scuola armati e aprirono il fuoco sui compagni e sugli insegnanti, uccidendo 14 persone. Quel giorno non commisero solo un gesto atroce, ma posero anche le basi per un immaginario fatto di esaltazione della violenza,disprezzo per la società e, soprattutto, emulazione. Un mondo che si muove soprattutto nelle zone grigie di internet, ma che quando esce lo fa nel peggiore dei modi. Antonio Pellegrino, giornalista per le testate Linkiesta, Il Foglio e La Ragione, nel suo libro Idioti dell’orrore, Indagine su stragisti di massa e subculture digitali (editore Linkiesta books) racconta a TheSocialPost il complesso intreccio tra stragi di massa, sottobosco online e meme, rivelando come gli stragisti e il loro pubblico virtuale abbiano creato un pantheon di esaltazione della violenza, veicolato, spesso, con la comicità. Attraverso casi come Columbine, Isla Vista e Christchurch, Pellegrino traccia un filo conduttore che unisce motivazioni politiche, sociali o puramente egocentriche, mettendo in luce il ruolo di forum anonimi e social network nella costruzione del mito degli stragisti.
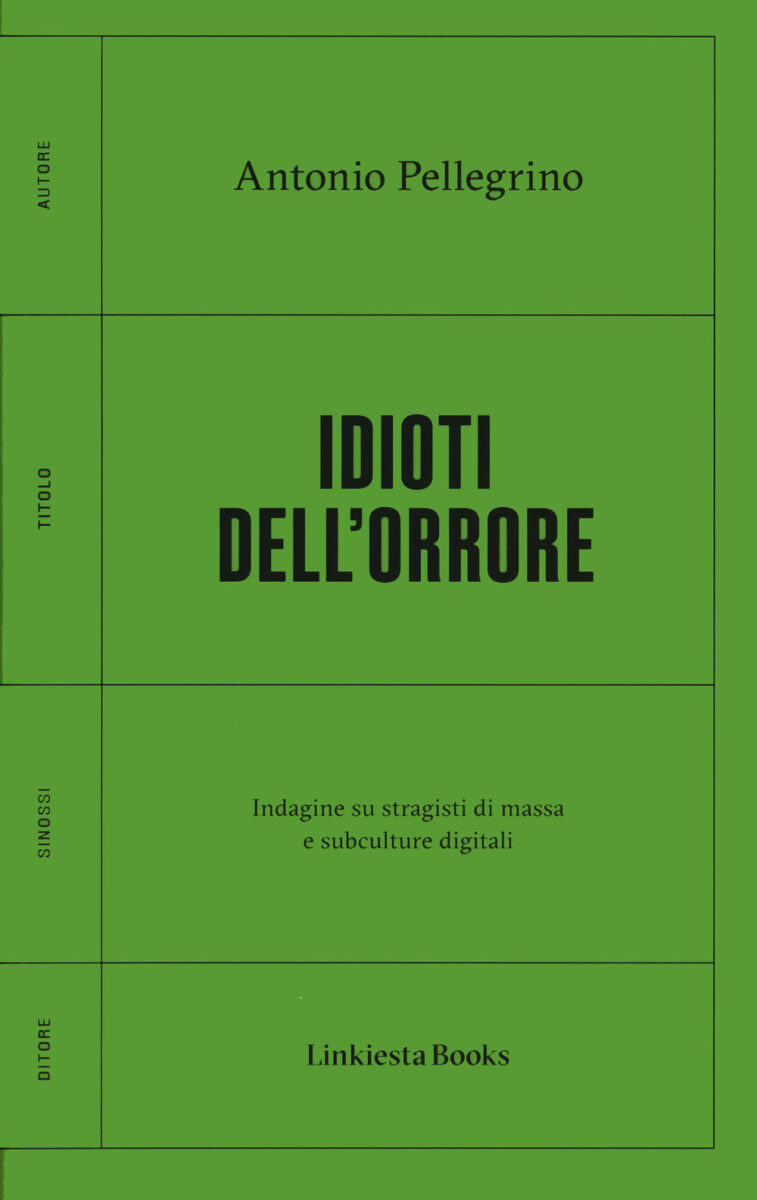
Singoli atti di violenza si trasformano così in fenomeni di massa, grazie a un uso strategico dei meme e a una manipolazione dell’estetica dei protagonisti. Dalle prime comunità di “Columbiner” alle ultime ondate di meme, Pellegrino mostra come il linguaggio visivo e la gamification of terror (vivere questi eventi come fossero videogiochi) abbiano reso queste tragedie elementi di attrazione per fasce sempre più ampie di utenti, alimentando un’empatia malata e una fascinazione tossica.
Chi sono gli “idioti dell’orrore”?
Da un lato, si riferisce a una nicchia di stragisti che si auto-celebra attraverso l’atto del mass shooting, propagandando se stessa con diari, video e manifesti. Dall’altro, c’è un sottobosco online – costituito da forum, canali social e community – che traduce questi contenuti in meme, ne amplia la portata e crea un vero e proprio mito. Questo duplice meccanismo trasforma le stragi in fenomeni pop, capaci di oltrepassare barriere linguistiche e geografiche.
Il centro del lavoro è proprio cercare un filo conduttore tra casi apparentemente divergenti: stragisti con giustificazioni politiche, motivazioni sociali o spinti da puro egocentrismo. Queste frange online, a volte consapevoli e a volte no, raggruppano autori di alcune delle stragi più efferate dei nostri tempi come Harris e Klebold (Columbine), Elliot Rodger (Isla Vista), Adam Lanza (Sandy Hook) e Brenton Tarrant (Christchurch) in un unico olimpo di “eroi” violenti, alimentato da un’estetica accurata e da dinamiche di fame-seeking (ricerca estenuante di fama, ndr).

Come mai inizia tutto con Columbine?
Pur non essendo il primo né il più efferato mass shooting negli Stati Uniti, quello di Columbine ha segnato una svolta diventando un vero fenomeno pop. Harris e Klebold hanno prodotto un’enorme mole di materiale personale: video diari, estratti di blog, testi autobiografici. I media li hanno rilanciati senza filtri insieme a dettagli personali, come i loro gusti musicali e la passione per i videogiochi sparatutto. Così si è innescato un effetto opposto a quello voluto, creando empatia in sottoculture considerate “reiette”. Da questi presupposti è nata una contronarrazione, generando i primi “Columbiner”: inizialmente erano dei semplici appassionati di true crime, che sui forum discutevano delle dinamiche e delle motivazioni che portarono alla strage. Ma nel tempo si sono aggiunti veri e propri simpatizzanti ed emuli. Fu in quei forum che emersero figure come Adam Lanza, autore della strage di Sandy Hook (la scuola elementare in cui aprì il fuoco causando la morte di 27 persone, 20 delle quali bambini, ndr).
Quindi che ruolo giocano social e forum anonimi nella diffusione di questi fenomeni?
Queste piattaforme, ad esempio il sito 4Chan, sono nate come spazi di anonimato e libertà di espressione, per poi diventare incubatrici di contenuti estremi e cassa di risonanza per gli stragisti. Ad esempio, Brenton Tarrant, autore nel 2019 degli attentati di Christchurch in cui morirono 51 persone, ha pubblicato il suo manifesto sul forum 8Chan. Anche Elliot Rodger, autore del massacro a Isla Vista, è stato utente di vari forum incel, gruppi di persone che si definiscono “celibi involontari” e attribuiscono il fatto di non avere una relazione al loro non essere attraenti. Rodger mette tutta questa retorica nei video-diari che pubblica prima della strage, diventando un idolo per queste persone.
Con il tempo però i confini tra le nicchie sono scemati: contenuti originariamente legati a gruppi ristretti, come i suprematisti bianchi o gli incel, hanno trovato spazio in community online più classiche, generando eco e visibilità.

Nel libro spiega come la diffusione di queste figure sia dovuta in gran parte ai meme. Come sono diventati uno strumento così potente?
I meme sono una forma di comunicazione visiva semplificatoria, capace di condensare concetti complessi in immagini immediatamente riconoscibili. Tarrant stesso lo afferma nel suo manifesto: “Diffondete meme”. È un invito a sfruttare il loro potere virale per propagandare ideologie etnonazionaliste o mitizzare i propri “eroi” violenti.
Negli anni Ottanta, i “Diari di Turner” (romanzo distopico pubblicato nel 1978 dallo scrittore neonazista statunitense William Luther Pierce, ndr) erano confinati a una cerchia ristretta. Oggi, grazie a un’ondata di meme partita da 4Chan, slogan e citazioni vengono sradicati dal contesto, ripetuti a oltranza e diffusi su Twitter, Instagram, creando empatia per stragisti o estremisti. Pensiamo ad alcuni casi di cronaca non troppo distanti da noi: Mangione, Unabomber o la presunta innocenza di Massimo Bossetti dimostrano come meme e retorica semplificata possano trasformare casi di cronaca nera in fenomeni popolari, sovrapposti a questioni politiche e sociali.
Ma perché gli autori di queste stragi decidono di condividerle sui social? Vogliono veramente diffondere un messaggio o sono solo in cerca di fama?
Gli attentatori costruiscono un’estetica — per Harris e Klebold trench nero, look gotico e riferimenti cinematografici — per aumentare il proprio fascino e la fama personale. Diversamente dal terrorismo politico tradizionale, che punta a obiettivi collettivi e a un nemico definito, molti mass shooter agiscono come “cani sciolti”, emulando gi loro “eroi”. La gamification del terrore accentua questo fenomeno: come nei videogiochi di sparatutto, anche nelle stragi si arriva a fare “ranking”, conteggiando le vittime e trasformando la carneficina in un macabro gioco. Columbine fu addirittura ricostruita come mappa del videogioco Doom, mostrando quanto il confine tra realtà e simulazione sia labile.

Una figura trattata nel libro è Joker. Cosa rappresenta e cosa c’entra con il fenomeno dei mass shooter?
Nel film “Il cavaliere oscuro – il ritorno” di Christopher Nolan, la trasposizione cinematografica di Joker, interpretato da Heath Ledger, ha permesso per la prima volta al giornalismo, e all’opinione pubblica in generale, di rendersi conto dell’esistenza di queste frange online. Nella notte tra il 19 e il 20 luglio del 2012, in quella che è conosciuta come la strage di Aurora, James Holmes, ex dottorando di neuroscienze ventiquattrenne, aprì il fuoco durante la proiezione della prima del film in un cinema, uccidendo 12 persone e ferendone 70. Holmes si identificava con Joker e con quello che per lui rappresentava: un eroe antisistema. Successivamente, il Joker di Joaquin Phoenix, vessato dalla società — un po’ alla Travis Bickle di Taxi Driver — ha fatto sì che alcuni sottoboschi online estremisti, soprattutto incel, lo prendessero come esempio, appropriandosene e rendendolo una bandiera.

Il fenomeno del mass shooting è soprattutto statunitense, in Italia c’è il rischio che si diffonda qualcosa di analogo?
Questo è molto legato anche alla diffusione culturale delle armi. In Italia non abbiamo quel tipo di rapporto: anche chi è appassionato o frequenta i poligoni è comunque una nicchia della nicchia, e non ha nulla a che vedere con l’estremismo americano. Negli Stati Uniti l’arma è parte della cultura trasversale, come il calcio da noi: ce l’ha chiunque, dal ricco al sottoproletario, dal democratico al repubblicano. Quindi no, non credo sia possibile una vera emulazione diretta in Italia o in Europa, almeno non nei modi americani.
Il rischio però esiste in altre forme. Il femminicidio, ad esempio, è un terreno dove vediamo una memificazione della violenza simile a quella dei mass shooting: meme su Giulia Cecchettin, contenuti apologetici su TikTok, e un immaginario digitale che trasforma il crimine in qualcosa da condividere o emulare. C’è stato anche un caso un po’ di tempo fa in cui un ragazzo ha ucciso una vicina “per sapere cosa si prova”. Sui suoi social poi si sono trovati molti like a meme su Filippo Turetta. Non voglio fare allarmismi o moralismi, ma è chiaro che il modello americano si trasforma, assume altre forme, e si insinua anche qui.


