
«Non voglio intromettermi in questioni che non mi riguardano direttamente ma, avendo a disposizione pochissimi strumenti per opporci all’Olocausto palestinese, un segnale, per quanto modesto, potrebbe consistere nel ritirare l’amicizia su Fb ai vostri “amici” ebrei, anche a quelli “buoni”». Così scrisse su Facebook tale Luca Nivarra, professore ordinario di diritto civile nell’Universitá di Palermo. Poi si scusò, più o meno, rivendicando un atavico rifiuto dell’antisemitismo, che sarebbe comprovato dalla sua iscrizione al PCI dagli anni Settanta. «Per noi – precisò – il rifiuto dell’antisemitismo era una precondizione».
Ricorda male il Navarra, perché il PCI, dopo la prima guerra arabo-israeliana, quando nel maggio del 1948 gli eserciti di Egitto, Siria, Libano, Iraq e Giordania attaccarono il neonato Stato di Israele, non fece che seguire la linea filo araba dell’Unione Sovietica, che pure aveva votato all’Onu a favore della sua istituzione. Una posizione ambigua, che si trasformò in palese antisemitismo con la guerra dei “sei giorni” del giugno 1967. Alfonso M. Di Nola spiegò che negli anni Sessanta del secolo scorso era possibile parlare «di uno slittamento o di una devianza delle scelte politiche antisionistiche in posizioni chiaramente antisemitiche […] Ed è codesta devianza che si qualifica, per quanto riguarda le sinistre italiane, come terzo strato dell’antisemitismo» (A. Di Nola, L’antisemitismo in Italia (1962-1972), Vallecchi 1973, p. 32).
«Ancora al principio degli anni Settanta – ricorda Giovanni Belardelli – poteva accadere che il manifesto di una sezione romana del Partito comunista ricordasse il rastrellamento degli ebrei della capitale compiuto dai tedeschi il 16 ottobre 1943, cioè l’episodio più grave nel “capitolo italiano” della Shoah, limitandosi però a parlare di “cittadini romani” deportati e dunque senza usare la parola ebrei» (G. Belardelli, Il tramonto del passato. La crisi della storia nella società contemporanea, Rubbettino 2025, p. 52).
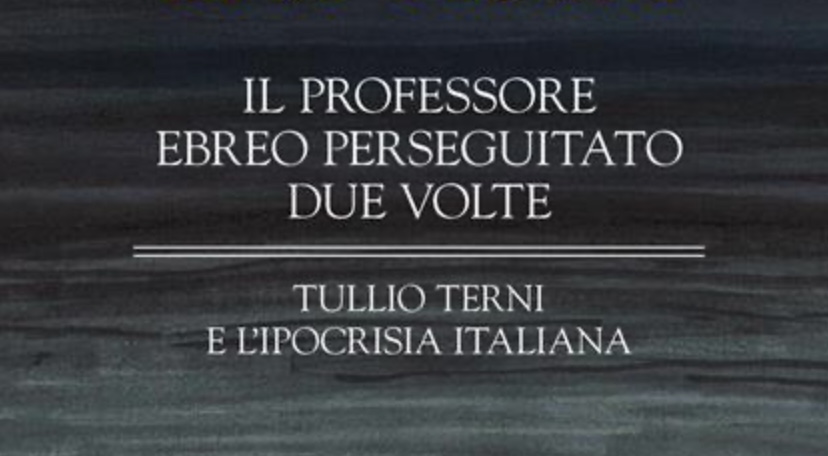
Il professor Nivarra invita a “lasciarli soli” gli ebrei, tutti, anche quelli “buoni”. Anche quelli, insomma, che non tifano Netanyahu e solo perplessi dalla prospettiva di rioccupare la Striscia di Gaza e di incrementare gli insediamenti dei coloni nei territori palestinesi. Se non è odio antiebraico questo, il Navarra dovrebbe spiegarci che cos’è l’antisemitismo, che è riemerso come un fiume carsico immediatamente dopo la strage perpetrata da Hamas il 7 ottobre 2023 e dilaga, non solo sui social. Per questo è molto importante che Pierluigi Battista sia tornato a mettere in evidenza l’antisemitismo che colpì gli ebrei italiani, quando Mussolini decise di espungerli dal consesso civile con le leggi razziali del 1938.
È importante perché aiuta a riflettere sul passato che non passa, sulle discriminazioni e le persecuzioni degli ebrei in quanto ebrei, sul presente che dimostra come ciò che è accaduto può accadere di nuovo, perché abbiamo presto dimenticato e non siamo riusciti a vaccinarci dal pregiudizio contro il “nemico” immaginario. E in effetti sta accadendo, sia pure in forme diverse ma non per questo meno infami.
È una storia poco conosciuta quella che Pierluigi Battista racconta in Il professore ebreo perseguitato due volte. Tullio Terni e l’ipocrisia italiana (La Nave di Teseo, 2025, pp. 144, € 16.00). Una rimozione conseguenza, appunto, dell’ipocrisia con la quale, dopo la Liberazione, la politica e gli intellettuali hanno affrontato il nodo delle leggi razziali, che – salvo rari casi – non suscitò neppure un minimo imbarazzo nella pubblica opinione. Certo, quella fascista era una dittatura e non era facile reagire. Di fatto “nominati”, quando i decreti furono sottoposti al voto della Camera il 14 dicembre 1938, i 351 deputati presenti approvarono compatti. Al Senato, di nomina regia, votarono contro solo 9 senatori su 164. Nessuno parlò. Tra gli assenti Benedetto Croce e i 9 senatori ebrei, 4 iscritti al PNF, due dei quali, Isaia Levi e Salvatore Segrè Sartorio, nominati durante il regime. D’altra parte Vittorio Emanuele III subito firmò. La Chiesa si preoccupò solo della sorte dei matrimoni misti. I professori universitari occuparono le cattedre dei colleghi radiati, né vollero lasciarle dopo la guerra. Negozianti e professionisti subentrarono serenamente ai discriminati.
Ma chi è stato Tullio Terni? Aveva un «viso bello e regolare dai tratti tipicamente semiti. Vestiva con ricercatezza, il monocolo incastrato sotto l’arcata sopraccigliare destra accentuava l’eleganza ottocentesca della sua figura sottile». La sua era “una conversazione brillante, piena di brio”. Era anche un uomo prodigo di galanterie, come Battista scopre dalle memorie di Rita Levi-Montalcini, allieva dello scienziato Giuseppe Levi, come a suo tempo Tullio Terni. Scienziato, anche lui. Nato a Livorno nel 1888, laureato in medicina a Torino, ufficiale medico sul Carso nella Grande Guerra, nel 1924 comincia la carriera universitaria a Padova come professore di istologia. Poi sarà direttore dell’istituto di anatomia e si dedicherà a ricerche sui neutroni.
Come molti italiani ebrei, nel 1922 Terni aderì al fascismo. Levi-Montalcini lo ricorda solo come «simpatizzante». In realtà Terni si occupa di scienza, non di politica. Segue la sua strada. Professore universitario, Accademico dei Licei. Accettò nel 1931 di giurare fedeltà al fascismo. Su 1200 professori universitari solo 12 non giurarono: Ernesto Buonaiuti, Mario Carrara, Gaetano De Sanctis, Giorgio Errera, Giorgio Levi Della Vida, Fabio Luzzatto, Piero Martinetti, Bartolo Nigrisoli, Edoardo Ruffini, Francesco Ruffini, Lionello Venturi, Vito Volterra. È bene ricordarli.
Fedele, almeno formalmente, con le leggi razziali la fedeltà di Terni non contò più niente. Toccò a tutti, anche ai militari, generali compresi. Radiato dall’università e dall’Accademia, si rifugiò a Firenze. Si sentì “un reietto in Patria”. «Le leggi antisemite – nota Battista – sono state un pogrom di Stato». Un pogrom durato a lungo. Abolita la legislazione antiebraica dal governo Badoglio,nel gennaio 1944, fu impossibile rientrare nelle università del Regno del Sud. Dopo la Liberazione fu difficilissimo in tutta Italia. A Tullio Terni la commissione di epurazione presieduta da Benedetto Croce negò anche la riammissione nella rinata Accademia dei Licei.
Per gli ebrei il clima non cambiò. Si ritrovarono spaesati. Tutti. L’antifascista Giorgio Levi Della Vida, che non aveva giurato, si ritrovò in un limbo, straniero in patria, in una patria che lo aveva rinnegato e non voleva ammettere il dramma che aveva vissuto. “La mia presenza – scrisse – rammentava qualcosa che avrebbero potuto fare e non avevano fatto”. Era diventato trasparente.
«Nelle prime ore della mattina del 25 aprile del 1946 – così l’incipit di Pierluigi Battista –, a un anno esatto dalla Liberazione, la moglie e i figli dello scienziato ebreo Tullio Terni, allarmati dall’insolito ritardo per la colazione di un uomo maniacalmente legato al culto della puntualità, si precipitarono nella sua stanza e trovarono il suo corpo oramai senza vita, avvolto in un plaid scuro. Terni aveva appena ingerito una fiala di cianuro, la stessa che qualche anno prima si era procurato, per non finire nelle grinfie delle SS, da uno dei laboratori scientifici di cui era stato prestigioso collaboratore».
Nelle pagine di Battista emerge chiarissimo il doloroso paradosso dell’epurazione post-bellica e post-fascista. La «vicenda di Tullio Terni – avverte – è una storia che parla di noi. Che forse parla troppo di noi. Di noi italiani. Di noi come comunità e delle scelte dei singoli. Delle nostre colpe. Dei nostri silenzi. Delle nostre omertà. Della nostra memoria selettiva. Del nostro manipolare la storia e la stessa vita passata a seconda delle nostre convenienze. Delle nostre complicità. Delle nostre viltà, perché no. Della nostra faciloneria e superficialità manichea con cui leggiamo il passato. Della nostra inclinazione a trasformare la storia in arma di propaganda. Del fascismo, dell’antifascismo, dei chiaroscuri, della cecità volontaria di fronte alla semplice evidenza dei fatti, delle biografie aggiustate, delle idées reçues. Della salvezza e della condanna. In questa fossa di smemoratezza è precipitata la storia di Tullio Terni. Colpito tre volte: dal razzismo, dagli epuratori che lo hanno linciato e dalla nostra dimenticanza».
Leggendo queste righe non si può sorvolare sui rischi del presente. La storia di Tullio Terni è tragica e simbolica. E purtroppo non è un unicum. Battista ricorda il suicidio, il 29 novembre 1938, del geniale editore ebreo Angelo Fortunato Formíggini. Anche lui aveva aderito al fascismo. Si lasciò cadere dalla Torre Ghirlandina della sua Modena.
Più simile a quella di Terni quanto poco nota è la storia del giornalista friulano ebreo Enrico Rocca. Sansepolcrista, redattore del “Popolo d’Italia” e del “Lavoro Fascista”. Dopo il 25 luglio dirige il quotidiano che ha cambiato nome in “Il lavoro italiano”. A Napoli collaborerà con la radio gestita dagli Alleati. Torna nella Roma liberata. Denunciato come fascista, il 20 luglio 1944 si toglie la vita. Nel suo diario, dopo le leggi razziali, aveva annotato: «Se al giudeo non rimanesse la gioia di ridere anche quando piange, come potrebbe sopportare tanti guai? E se talvolta non ride, giuro che la colpa non è sua». C’è da chiedersi se l’augusto professor Luca Nivarra ne sia consapevole.


