
Gad Lerner si definisce ebreo “dissidente”. Non dalla religione israelitica, mi par di capire. Il che sarebbe più che legittimo. Come legittima è la scelta di un cattolico di essere, pur battezzato, “non praticante”, o critico del Papa regnante pro tempore. Immagino sia legittimo anche per un buddista e un islamico. Sono questioni di coscienza. Sicuramente Lerner ci tiene a definirsi “dissidente” dalle scelte politiche dello Stato di Israele. Una dissidenza antica, in verità, se ho compreso il senso delle posizioni da lui assunte nel corso dei decenni, e con chiarezza ribadite di fronte alla reazione di Israele dopo la strage perpetrata da Hamas il 7 ottobre del 2023 al Nova Festival.
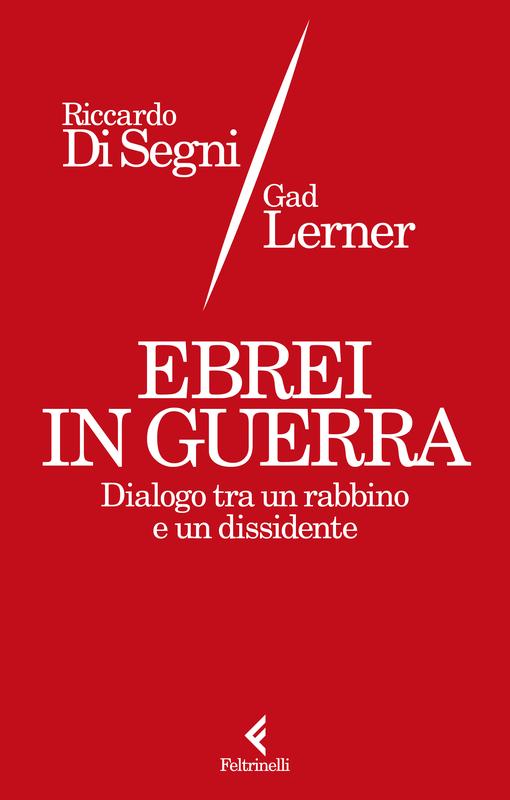
Con il passar dei mesi, mentre la guerra contro Hamas si faceva sempre più intensa e provocava vittime civili nella Striscia di Gaza, Lerner, nel febbraio 2025, è stato tra sottoscrittori di un accorato appello «contro la pulizia etnica a Gaza e in Cisgiordania». Appello molto criticato dalle Comunità ebraiche italiane, con le quali le sue «divergenze si sono aggravate».
Questa sua divergenza è il cuore del duello a colpi non di sciabola ma di fioretto, se così si può dire, tra Lerner e il rabbino capo della Comunità ebraica romana rav Riccardo Di Segni pubblicato nel libro Ebrei in guerra. Dialogo tra un rabbino e un dissidente (Feltrinelli, 2025, pp. 175, € 16.00) firmato dai due protagonisti. Contrapposte erano le posizioni nei colloqui privati. E contrapposte restano nel testo consegnato ai lettori. Consiglio di leggerlo con attenzione. Anche se un po’ mi imbarazza il vittimismo che trasuda nelle pagine introduttive vergate da Lerner, che lamenta una sorta di censura a suo danno.

«Nell’ottobre 2024 – ricorda Lerner – Anna Foa mi aveva segnalato che la libreria ebraica Kiryat Sefer, l’unica del ghetto di Roma, rifiutava la vendita ai clienti che lo chiedevano del mio Gaza. Odio e amore per Israele, così come di altri testi sulla guerra scritti da autori sgraditi alla Comunità. Ho cercato conferme e le ho avute. Questo è il messaggio ricevuto dall’insospettabile Enrico Mentana, che abita da quelle parti: “Ci sono tutti, da Bernard-Henri Lévy a Pigi Battista, da Meotti a Scipione Rossi, da Kepel a Della Pergola, ma né Anna Foa, né Davide Lerner, né Gad Lerner”».


Mi dispiace che Lerner se la sia presa per l’assenza del suo libro – che a suo tempo non ho letto – dagli scaffali della libreria della Comunità. Se lo consola mi mancano anche Gilles Kepel (Olocausti. Israele, Gaza e lo sconvolgimento del mondo dopo il 7 ottobre (Feltrinelli, 2004) e Davide Lerner (Il sentiero dei dieci. Una storia tra Israele e Gaza (Piemme, 2004).
Sono invece onorato che in quegli scaffali fosse presente il mio Anche Israele, però… L’ombra lunga dell’antisemitismo (Intermedia, 2024). Da autore, comprendo bene l’ansia da autore. Quante volte ho cercato invano negli scaffali Feltrinelli un mio libro… capisco. Ma, insomma, a Gad gli passerà. Piuttosto gli ricordo che non è “politicamente corretto” chiamare “ghetto” quello splendido angolo di Roma che circonda da tre lati il Tempio Maggiore. Ormai anche i romani lo definiscono “ex ghetto”, visto che il ghetto papalino non esiste più dal 1870.

Ma, messo da parte l’imbarazzo, veniamo al contenuto del libro. O, meglio, alla posizione di Di Segni, nettamente critica di quella dell’interlocutore. «Lerner – nota il rabbino – si è fatto espressione di un forte dissenso, culminato nell’appello contro la pulizia etnica che Israele praticherebbe a Gaza e in Cisgiordania. Si trattava di un “copia e incolla” nel testo e nella grafica di un appello pubblicato negli Stati Uniti e in Australia. In Italia lo hanno firmato circa duecentoventi persone qualificandosi come ebrei. La maggioranza probabilmente lo è, altri sono di origine ebraica. Ho espresso con pacatezza la ragione della mia critica: la maggior parte degli ebrei italiani è contro la pulizia etnica e questa posizione non è patrimonio esclusivo di una minoranza di firme. Se gli altri, pur contro la pulizia etnica, non firmano è perché ritengono che la denuncia, nel modo in cui è stata fatta, non tenga conto della complessità della situazione. Nella sua limitatezza risulta solo un ennesimo attacco diffamatorio contro Israele a totale beneficio non della verità, ma della propaganda organizzata dalla controparte. Inoltre questo mettersi in mostra come ebrei per segnalare che si è ebrei buoni, a differenza degli altri che non lo sono, suona come una dissociazione funzionale alla difesa di posizione e prestigio sociale. Sembra il prezzo da pagare per essere accolti da qualche parte, una captatio benevolentiae. Per questo l’ho trovato inopportuno. C’è differenza fra essere buoni ebrei ed ebrei buoni. Molti dei firmatari non li conosco. Di altri, che conosco, credo si ricordino di essere ebrei solo per firmare questo tipo di appelli».
Risposta pacata, ma tagliente. «Ciò da cui prendo le distanze – chiarisce Di Segni – sono innanzitutto il tono ed espressioni come “indifendibile”, “massacro”, “ferocia”, “spargimento di sangue senza precedenti”. Sì, è in corso una guerra che è feroce come tutte le guerre. Comporta lutti e rovine. Preferirei mille volte che non accadesse. Ma, senza sminuire la portata degli avvenimenti, a dispetto della visione di chi la definisce una guerra destinata a restare senza vincitori, credo sia possibile il contrario: se non verrà fermata dalle grandi potenze, questa guerra potrà avere dei vincitori, anche se a un prezzo altissimo per entrambe le parti. Forse i palestinesi e chi li supporta si convinceranno che a loro non conviene più sognare una “free Palestine”, “from the river to the sea”, che significa la distruzione totale d’Israele ma che al momento comporta la loro distruzione. Certo, per un ebreo che s’interroga sui valori della propria storia e tradizione anche una sola vittima e la sofferenza in campo nemico pongono una domanda morale. È lecito e anzi doveroso tormentarsi su questi problemi. Ma al banco degli accusati ci stanno solo Israele e gli ebrei che lo appoggiano. Il mondo è insanguinato da massacri che fanno vittime in proporzione decuplicate e centuplicate rispetto a quanto avviene in Israele e Palestina, ma non gliene importa niente a nessuno».

Già, perché se gli islamisti radicali fanno strage di cristiani in Nigeria la stampa non ne parla? Tante domande restano senza risposte. Perché è quasi proibito sottolineare che i gazawi sono anch’essi vittime di Hamas? Perché i tunisini hanno lasciato una Global Sumud Flotilla troppo fitta di “frociaggine”, per dirla con Papa Francesco? La comunità LGBT+ sa che nella democrazia israeliana si può scendere in piazza ripetutamente per criticare il premier Netanyahu e “persino” organizzare il Gay Pride? Si è mai provato a farne uno nella Striscia, o in Iran? Troppe domande, scomode. Poche risposte. Poche righe sui tanti conflitti “dimenticati”, che non “meritano” appelli dolenti, mentre si moltiplicano quelli contro Israele, da tutte le latitudini. Sarò distratto, ma non ricordo appelli sulla sorte degli uighuri in Cina. Anche loro hanno diritto di vivere in pace per quel che sono. La scomoda verità è che gli ebrei, israeliani o diasporici, grava un pregiudizio antico, un antisemitismo diffuso, che in alcuni periodo lavora sotto traccia, ma sempre pronto a riemergere con violenza. Gli ebrei – capaci tra loro di litigare su tutto – restano il “nemico”ideale, con l’antisionismo che dell’antisemitismo rappresenta solo l’altra faccia della stessa medaglia.
Con il 7 ottobre gli ebrei – loro malgrado – sono tornati al centro del dibattito pubblico, coinvolgendo anche le comunità italiane. Il dibattito delle idee è sempre legittimo e anzi necessario. Ma Riccardo Di Segni avverte, parlando molto chiaramente, che «Chi sottoscrive appelli pubblici contro Israele in nome del suo ebraismo può avere ogni tipo di motivazione possibile, persino teoricamente virtuosa, ma non tiene conto delle ripercussioni devastanti in questa guerra mediatica. In molti casi è in piena contraddizione con la sua identità ebraica, espressa solo con una firma e quasi mai con una partecipazione alla vita comunitaria e alle preoccupazioni e ai rischi che questa oggi comporta. Perciò la gente è arrabbiata. Come vedi – dice a Lerner – non reagisco a male parole, sto provando a dialogare con te, ma le tue scelte pubbliche non riesco a proprio a giustificarle».
E non teme Di Segni di affrontare questioni delicatissime, a cominciare dall’accostamento della guerra di Gaza all’Olocausto. «Gaza – replica a Lerner – serve a cancellare Auschwitz ma non nel modo che tu dici. Per te se gli ebrei denunciassero quello che il governo israeliano fa a Gaza l’opinione pubblica riuscirebbe a distinguere tra ebrei buoni e governo cattivo e manterrebbe un ricordo rispettoso della Shoah e dei discendenti delle sue vittime. La penso in modo molto differente. Siamo davanti a un perfetto tranello mediatico calcolato. La risposta israeliana era inevitabile e Hamas e i suoi sostenitori lo avevano previsto. Il gioco è quello di dimostrare che Israele è cattivo e spietato, che il credito della Shoah è finito e che le vittime sono diventate persecutori. Questa frase me la sono sentita dire durante la Guerra del Libano nel1982. E già l’aveva messa in circolazione un intellettuale comunista come Italo Calvino nel 1968, un anno dopo la Guerra dei sei giorni. Calvino, che pure aveva una moglie ebrea, non poteva tollerare che gli ebrei vincessero una guerra. E questo già nel 1968!»
È denso, complesso, questo dialogo tra il rabbino e il dissidente, che tocca il mondo ebraico ma non solo, compresa la storia delle posizioni culturali delle comunità italiane e dei loro rapporti con le destre e le sinistre politiche. A parte il fatto, ovvio, che un ebreo – ovunque viva – è libero come chiunque di considerarsi di destra o di sinistra, di percepirsi conservatore o progressista, di essere, eventualmente, vicino alla tradizione sionista socialista o a quella revisionista, non si può negare l’influenza degli avvenimenti internazionali e italiani dei decenni passati. E bene fa Di Segni a spiegare a Lerner la situazione attuale, partendo da lontano.
«Dal lontano 1967, anno della Guerra dei sei giorni – ricorda il rabbino – il blocco sovietico fece una scelta di campo pro araba e antisraeliana che orientò i partiti comunisti e con loro una parte dell’opinione pubblica. Così si è consumata una progressiva crisi di distacco della sinistra da Israele, su cui di certo ci confronteremo. La questione palestinese è diventata una bandiera aggregante per tutti i movimenti di sinistra e di protesta, forse l’unica rimasta rispetto a tante altre battaglie. Quello che vediamo esplodere nelle piazze dal 7 ottobre 2023 è il risultato di decenni di indottrinamento. La conseguenza è che gli ebrei, che in maggioranza si identificavano nelle sinistre, si sono sentiti progressivamente emarginati, giudicati, condannati. Cacciati dalla casa che avevano contribuito a costruire».

«Hai un bel dire – replica a Lerner – che la manifestazione romana “per Gaza” del 7 giugno 2025 indetta da Pd, M5s e Avs a cui pure tu hai partecipato è stata attenta a non macchiarsi di antisemitismo. La prospettiva è un’altra. Tre diversi partiti di sinistra che insieme sono in minoranza e non riescono a convincere a votare un referendum, che non sono scesi in piazza con tanto impeto e mobilitazione contro ingiustizie sociali e guerre da altre parti del mondo, hanno trovato come unico fattore aggregante il processo a Israele, facendo leva su un sentimento di misericordia per chi soffre: e mentre tu sul palco facevi qualche distinguo, gli altri avevano la mano pesante. Non sarà antisemitismo, manon è una dichiarazione di amore. Tutta questa ostilità di fondo, al di là delle dichiarazioni ufficiali, si avverte a livello istintivo. Ed è la cosa che fa più male. Gli ebrei sono in cerca di una casa politica, condivisione, alleanza, protezione, e la maggioranza di loro non la trova, e qualcuno purtroppo pensa di trovare alleati in persone e movimenti discutibili per il loro passato e per il loro futuro. La tristissima realtà è che, se ritrovano sostenitori a destra, alcuni sinceri, altri controversi, è perché la sinistra si comporta per lo più in modo ostile, o apertamente o paternalisticamente».
Né gli israeliani né gli ebrei italiani – è bene chiarirlo – vanno cercando o hanno bisogno di un pietoso paternalismo.


