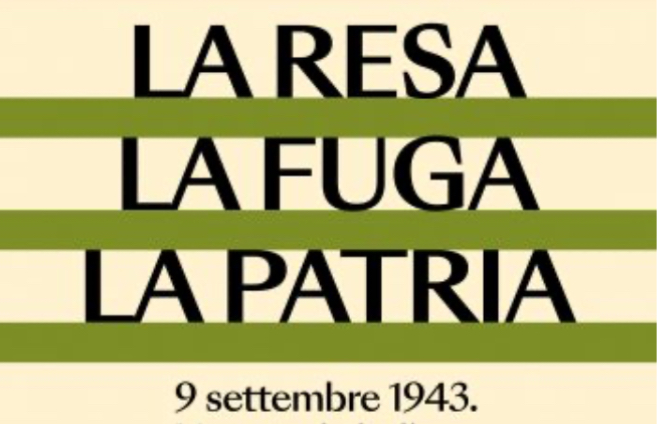
Alle 17.30 dell’8 settembre 1943 il comandante delle forze armate Alleate generale Dwight David Eisenhower annuncia da Radio Algeri che il Regno d’Italia ha firmato l’armistizio. A Roma erano le 18.30. L’annuncio era tardivo, perché la firma era avvenuta il 3 settembre a Cassibile, frazione di Siracusa. Ma, contestualmente, era prematuro rispetto alle aspettative dal maresciallo Pietro Badoglio, che il Re Vittorio Emanuele III aveva nominato capo del governo al posto di Benito Mussolini, rovesciato dal Gran Consiglio nella notte tra il 24 e il 25 luglio.
Le difficili trattative segrete con gli Alleati erano in corso da settimane. Raggiunta l’intesa, Badoglio aveva chiesto che l’armistizio fosse reso pubblico dopo almeno 15 giorni, per consentire alle Forze Armate italiane di prepararsi alla inevitabile reazione dei tedeschi che, pur dubbiosi, erano fermi alla sua dichiarazione del 25 luglio: “La guerra continua e l’Italia resta fedele alla parola data”. Ma Eisenhower aveva fretta di chiudere la partita italiana per occuparsi dell’invasione della Francia settentrionale occupata dai nazisti.

Preso in contropiede, Badoglio, alle 19.45, parlò dai microfoni dell’Eiar: “Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria […] ha chiesto un armistizio. La richiesta è stata accolta”. Gli italiani pensarono che la guerra fosse finita, come avevano sperato anche il 25 luglio. Niente di più falso. Non di armistizio si trattava, in realtà, ma di resa incondizionata. Peraltro definita in due tempi. A Cassibile si firmò il cosiddetto “armistizio breve”. Quello “lungo” fu firmato a Malta, il 29 settembre successivo. Il suo contenuto fu reso noto solo a guerra finita, nel novembre del 1945.
Sulla alla complessità politica e militare degli eventi di quei giorni si ragiona nel volume La resa, la fuga, la Patria. 9 settembre 1943. Una storia italiana (Solferino, 2025, pp. 318, € 19.90). Curato da Marco Patricelli, raccoglie gli atti del convegno di studi svoltosi a Pescara il 9 settembre 2023, con i contributi di Ernesto Galli della Loggia, Lutz Klinkhammer, Anna Longo, Aldo A. Mola, Roberto Olla, Francesco Perfetti e Luciano Zani. 9 settembre, dunque, non 8. Una data “atipica”, scelta simbolicamente perché, se è vero che l’8 settembre cambia radicalmente la storia nazionale, anche il frettoloso “trascolo” del Re dal Quirinale a Brindisi via Pescara e Ortona, segna una frattura che porterà alla fine della monarchia, che con casa Savoia era stata protagonista del Risorgimento e dell’unità nazionale.

Gli autori non si occupano solo del “trasloco”, ma ampiamente del prima e delle conseguenze della scelta del Sovrano. In sintesi, le tesi espresse sono due. Aldo A. Mola è contrario a definire spregiativamente “fuga” il trasferimento in Puglia, appellandosi a Carl von Clausewitz: «la ritirata nel proprio territorio non è una fuga: fa parte delle regole della guerra». La decisione, in effetti, fu presa in fretta e furia – peraltro contro il parere del principe ereditario e futuro Luogotenente e re di maggio Umberto – perché gli Alleati non avevano accolto la richiesta di un loro sbarco a nord di Roma, in Toscana o nelle Marche, che avrebbe consentito alle Forze Armate italiane di riorganizzarsi e di combattere contro i tedeschi in marcia verso Sud. All’Italia non fu riconosciuta la dignità di alleata, e anche la “cobelligeranza” fu molto contrastata.
Nella concitazione di quei momenti, si ragionò su una partenza aerea per la Sardegna, ancora solo italiana, ma sembra sia stata archiviata perché la regina Elena non amava volare. Così si scelse la Puglia, non occupata dai tedeschi né dagli Alleati. Quindi un territorio ancora ancora formalmente sotto la piena sovranità del Re. Non fuga, dunque, ma ragionata scelta politica e istituzionale.
Ben diversa l’opinione di Marco Patricelli, che anche in un suo coevo audiolibro – Tagliare la corda. 9 settembre 1943. Storia di una fuga – scrive nettamente che «Fu una fuga, un abbandono, non fu un allontanamento e neppure un trasferimento. […] Tagliando la corda, venne reciso senza gloria e nel peggiore dei modi immaginabili il nodo che aveva legato una dinastia e un intero sistema ai destini dell’Italia». Un dibattito ancora così acceso può sembrare inutile dopo più di ottant’anni, ma il fatto che ancora si discuta testimonia come sia stato difficile archiviare anni tragici, e così percepiti da un popolo rimasto senza riferimenti e in preda anche – nel Centronord – a una sanguinosa guerra civile.

Ne è derivata anche – come rileva Ernesto Galli della Loggia – una «rimozione-oblio di quanto veramente accadde l’8 settembre». Con due ricadute: da un lato l’errata convinzione che «a suo modo anche l’Italia avrebbe vinto la guerra», dall’altro che «l’Italia quella guerra stessa non l’aveva voluta, che la guerra era stata imposta dal fascismo». Convinti di questo, senza tener conto delle responsabilità del popolo che aveva per due decenni sostenuto Mussolini, gli italiani si stupirono e furono risentiti quando scoprirono il vero contenuto del trattato di pace. Ne derivarono – sottolinea Galli della Loggia – la «disintegrazione dell’idea di Stato, il discredito dell’autorità pubblica, il venire meno per tanta parte dell’idea di un vincolo obbligante della comunità, e con esso di qualunque idea di un destino comune». La morte della patria, insomma, da tanti all’epoca percepita.
Ha ancora un senso interrogarsi su possibili scelte diverse di Vittorio Emanuele III? Ebbe ragione o ebbe torto? «Certo – spiega Francesco Perfetti – le modalità con le quali il trasferimento da Roma a Brindisi via Pescara venne realizzato e gli eventi che lo precedettero e accompagnarono furono gestiti malissimo e furono essi, davvero, i responsabili di una crisi militare, politica e morale quale non si era mai vista. Una crisi che può essere sintetizzata nella espressione pregnante di “morte della patria”. Anche se – e desidero sottolinearlo con forza e decisione – fu anche la premessa per una “resurrezione della patria” che avrebbe portato alla costruzione di una nuova Italia, libera e democratica».
Al di là dei dettagli sapientemente ricostruiti dagli autori, il libro costringe a riflettere. Ed è un bene.


