
Il luddismo è un riflesso antico quanto la civiltà. Ogni epoca ha creduto che la novità fosse una minaccia, che l’innovazione avrebbe spezzato la continuità dell’umano, che il futuro fosse un peggioramento del presente. La nostalgia per il passato e la diffidenza verso ciò che rompe la routine non appartengono solo ai conservatori culturali, ma all’istinto profondo dell’uomo che teme ciò che non controlla. La storia del mondo è costellata da persone convinte che l’ultimo passo tecnologico fosse un passo nel baratro. L’idea che “qualcosa sia andato storto” non nasce oggi. È un classico: cambia solo l’oggetto della paura. Oggi è la rete, oggi sono i social, oggi è la intelligenza artificiale, ieri era la stampa, la ferrovia, la televisione. In questo solco antico si inserisce il libro di Riccardo Luna, Qualcosa è andato storto, che racconta la fine dell’utopia digitale, il fallimento dell’ideale connettivo, la trasformazione dell’internet della libertà nell’internet della manipolazione. È un atto d’accusa lucido, informato, persino necessario. Ma è anche un racconto monco, perché ignora la memoria del mondo precedente. Per dire che il nuovo ha rovinato tutto bisogna aver rimosso quanto poco funzionasse il vecchio.
Il mondo pre-digitale non era un luogo più giusto, era soltanto meno trasparente. La rete non ha creato il disordine, lo ha reso visibile. Prima dell’era del web, i sistemi di informazione erano verticali, filtrati, lenti, inaccessibili. Prima dei social, la parola pubblica non era libera ma concessa. Chi oggi rimpiange “il tempo in cui non c’era tutta questa confusione” in realtà rimpiange il tempo in cui la confusione c’era, ma non si vedeva. La rete non ha reso l’umanità peggiore, ha tolto alla cattiveria il privilegio dell’ombra.
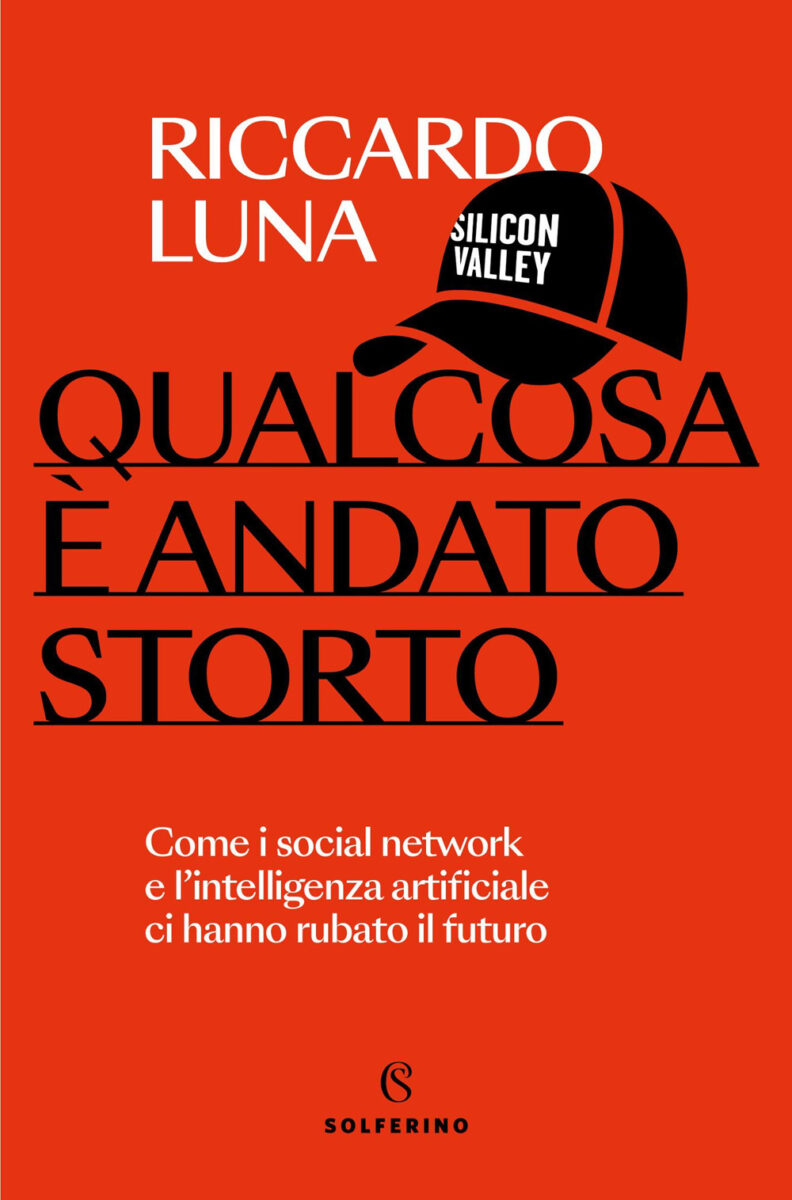
I social non creano l’odio: lo rendono misurabile. La strada non crea i briganti, li fa uscire dal bosco
Si accusa la rete di aver moltiplicato l’odio, quando la rete ha soltanto eliminato la sua invisibilità. Prima dei social, l’odio era distribuito in luoghi privati, in bar, cortili, redazioni, mense, circoli, salotti, e tutto si disperdeva senza lasciare tracce. Oggi lo vediamo perché lo possiamo contare, archiviare, tracciare. La rete non crea il buio: accende la luce in stanze che prima restavano sigillate. La sensazione che l’umanità sia peggiorata è una distorsione ottica: vediamo ciò che già esisteva ma che ora non può più nascondersi. Il dato più rilevante non è che esista l’odio digitale, ma che per la prima volta nella storia esista il suo archivio. L’impressione di degenerazione è il prezzo della trasparenza.
È lo stesso errore per cui si crede che un aumento dei processi per corruzione significhi più corruzione, quando significa solo più indagini. La rete ha tolto al male il vantaggio della dissolvenza. Un insulto oggi non scompare, resta tracciabile. Un abuso oggi non evapora, diventa prova. Una menzogna non vive più indisturbata, viene messa alla prova della verifica collettiva. Dire che i social “creano odio” è come dire che le strade “creano i briganti” solo perché li fanno uscire dal bosco. I briganti c’erano già. Ora li vediamo. E vederli non è il problema: è l’inizio della soluzione.
Le fake news non le ha inventate internet: esistono dai tempi della stampa
Lo stesso equivoco riguarda le fake news. Si sostiene che siano figlie della rete, ma le più devastanti falsità della modernità sono nate nel mondo pre-digitale, trasmesse da libri, giornali, pamphlet, enciclopedie, catechismi politici. Il caso più famoso resta quello dei Protocolli dei Savi di Sion, uno dei più colossali falsi editoriali mai prodotti, stampato alla fine dell’Ottocento, ristampato per decenni, usato per giustificare pogrom, persecuzioni, leggi razziali, stermini. Non circolava su Twitter ma in librerie, scuole, circoli, parlamenti. Quando una bugia veniva impressa sulla carta, si trasformava in verità non perché fosse vera, ma perché era stampata. La carta creava autorità senza verifica. Il mondo offline era un luogo in cui l’errore non si correggeva: si moltiplicava.
Internet non ha inventato la menzogna, ma ha inventato il suo antidoto: la reversibilità. Una bufala digitale può essere confutata, verificata, smentita, e la sua smentita può circolare più della sua origine. Non scompare la falsità, scompare la sua eternità. Le enciclopedie sono state piene di errori, ma nessuno poteva modificarle. Oggi un paragrafo sbagliato su Wikipedia viene corretto in minuti. Ciò che viene denunciato come “mondo della disinformazione” è in realtà il primo mondo in cui la disinformazione non rimane stabile. Il digitale non moltiplica la menzogna, moltiplica la possibilità di contestarla.
L’intelligenza artificiale non sostituisce l’uomo, lo prolunga
Lo stesso schema si ripete con la intelligenza artificiale, descritta come minaccia finale all’identità umana. Ma l’AI non è la fine della storia: è l’ultimo capitolo di un processo millenario in cui l’uomo costruisce protesi per superare i propri limiti. La ruota ha esteso le gambe. Il libro ha esteso la memoria. La stampa ha esteso la voce. La macchina ha esteso le braccia. Il computer ha esteso il calcolo. L’AI estende l’immaginazione, la combinazione, la previsione. Non annulla l’uomo: lo estende oltre se stesso.
La paura che “tolga lavoro” deriva da un’idea statica di lavoro, come se la storia non avesse già dimostrato che ogni nuova tecnologia libera tempo, forza, pensiero, e costringe l’uomo a ridefinire il proprio ruolo. Nessuno oggi invoca il ritorno del mondo pre-elettrico o delle miniere a mano. Ogni epoca crede di difendere il lavoro, ma in realtà difende la familiarità. L’AI non toglie dignità, la redistribuisce. Non decide chi siamo: ci costringe a deciderlo.
Chi denuncia la perdita dell’umano dimentica che la sua massima espressione non è la fatica, ma il linguaggio, la creatività, la libera intenzione. L’AI non ci minaccia perché pensa: ci interroga perché ci libera dal ripetere. Dopo la ruota non abbiamo smesso di camminare. Dopo l’AI non smetteremo di pensare. Smetteremo, al massimo, di pensare male.
Il punto, allora, non è che “qualcosa è andato storto”. Il punto è che qualcosa è diventato visibile. La rete non ha peggiorato l’uomo, ha peggiorato la nostra percezione dell’uomo perché lo ha reso trasparente. Il pessimismo tecnologico nasce sempre dalla nostalgia, mai dall’analisi. Il futuro non lo costruiranno quelli che rimpiangono il mondo di ieri, ma quelli che ricordano com’era, e decidono di farlo avanzare.
La rete ci ha dato la voce. I social ci hanno dato la traccia del nostro stesso linguaggio. L’intelligenza artificiale ci restituirà la mente espansa. Il resto non dipende dalla macchina. Dipende da noi.


