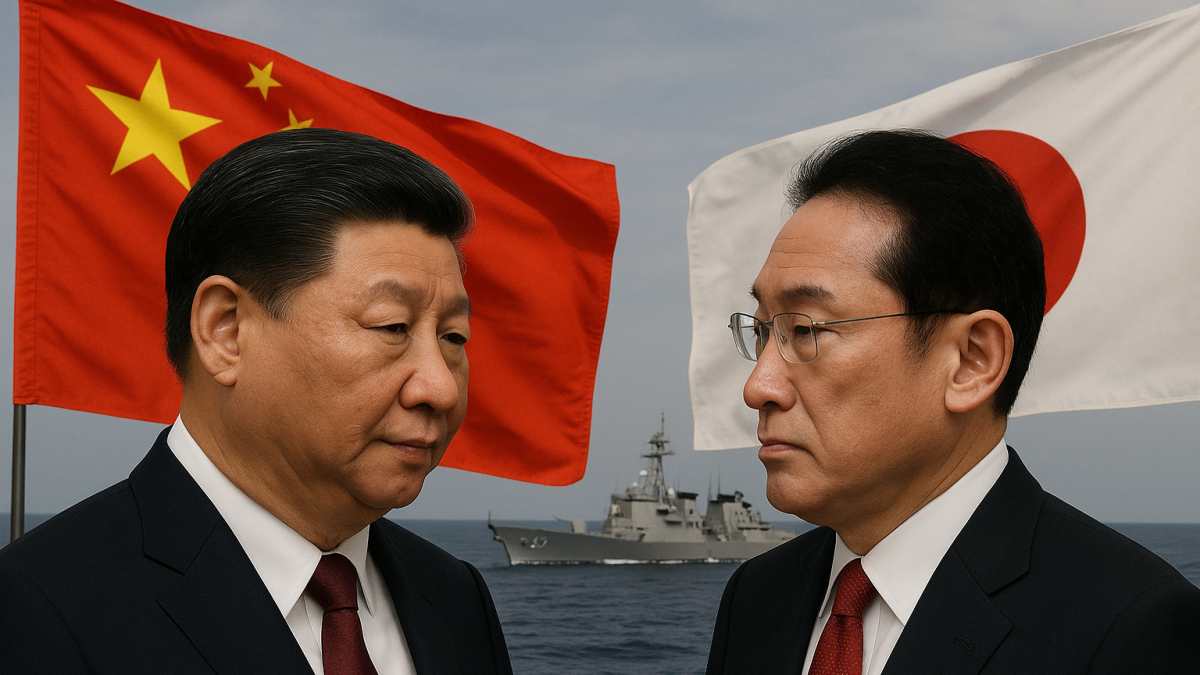
Cina e Giappone condividono una lunga storia di relazioni travagliate, segnata da guerre e rivalità fin dall’epoca moderna. Dalla sconfitta subita dalla Cina nella prima guerra sino-giapponese (1894-95) all’invasione giapponese durante la Seconda guerra mondiale, le ferite storiche hanno alimentato diffidenze reciproche e sentimenti nazionalistici duraturi. Ancora oggi, nonostante i robusti legami economici e culturali sviluppatisi negli ultimi decenni, nel lungo periodo la questione sino-giapponese appare segnata da un’ostilità latente che potrebbe riemergere apertamentel. In altre parole, la vecchia rivalità non è mai del tutto scomparsa ed entrambe le società conservano memorie e rancori che possono riaccendersi in periodi di tensione.
Le frizioni odierne si concentrano su questioni territoriali e strategiche. In primo piano vi è la disputa sulle isole Senkaku (Diaoyu in cinese), un piccolo arcipelago disabitato nel Mar Cinese Orientale amministrato dal Giappone ma rivendicato dalla Cina: episodi come l’istituzione da parte di Pechino di una zona di identificazione aerea sovrapposta alle isole contese hanno innescato periodiche crisi diplomatiche. A ciò si aggiunge la crescente competizione geopolitica dovuta all’ascesa della Cina come potenza regionale e al relativo declino (quantomeno proporzionale) del Giappone. Pechino vede con sospetto l’alleanza nippo-americana e la presenza militare statunitense in Asia orientale, mentre Tokyo teme l’espansionismo cinese e le possibili “revanche” storiche. Non a caso, la leadership comunista cinese ha spesso alimentato il sentimento nazionalista anti-giapponese come collante interno, mentre il Giappone, da parte sua, rivendica il diritto di mantenere lo status quo territoriale e la propria sovranità sulle isole contese. Questo equilibrio precario fa sì che le relazioni sino-giapponesi restino soggette a ondate di gelo diplomatico e riavvicinamenti temporanei, in un contesto dove nessuna delle due potenze intende apparire debole di fronte all’altra.
Capacità militari e strategie navali
Parallelamente alle tensioni politiche, entrambi i paesi hanno intrapreso negli ultimi anni un potenziamento delle proprie capacità militari, alimentando una corsa agli armamenti nella regione dell’Indo-Pacifico. La Cina ha investito massicciamente nella modernizzazione delle sue forze armate, in particolare della Marina militare (PLAN), ormai la più numerosa al mondo per numero di unità. Pechino sta varando portaerei di nuova generazione, ampliando la flotta sottomarina e sviluppando un arsenale avanzato di missili balistici e da crociera “anti-nave” e “anti-accesso” pensati per tenere a distanza le forze statunitensi e colpire obiettivi strategici nemici (come grandi navi da guerra o basi aeree) nel caso di conflitto. Questa dottrina marittima di Pechino presenta notevoli somiglianze con quella del Giappone imperiale durante la Seconda Guerra Mondiale: la Cina punta infatti a proteggere le proprie rotte di approvvigionamento marittimo (soprattutto energetiche) e, al contempo, a poter minacciare le vie di rifornimento dei paesi alleati degli Stati Uniti nella regione, in primis Giappone, Taiwan e Corea del Sud. In quest’ottica, la rapida espansione del programma di portaerei cinese e il rafforzamento della componente sottomarina mirano a consentire alla flotta del Dragone di spingersi oltre le cosiddette “catene di isole” che circondano la Cina (dall’arcipelago giapponese fino alle Filippine e all’Indonesia), assicurandosi l’accesso all’oceano aperto in caso di guerra e potendo così proiettare potenza ben oltre i propri mari costieri.
Dal canto suo, anche il Giappone ha iniziato ad allontanarsi dalla postura di difesa esclusivamente territoriale adottata nel dopoguerra, intraprendendo un riarmo significativo. Negli ultimi anni Tokyo ha aumentato il budget della difesa con l’obiettivo di portarlo a livelli mai visti dai tempi della Guerra Fredda, avviando l’acquisizione di capacità militari più offensive in risposta al cambiamento dello scenario strategico. Il governo giapponese ha approvato nuovi documenti strategici che enfatizzano la deterrenza integrata e la possibilità di condurre attacchi preventivi o di ritorsione contro basi missilistiche nemiche in caso di minaccia (“capacità di contrattacco”). Sono in fase di sviluppo e acquisizione missili a lungo raggio, come versioni potenziate dei Tomahawk americani, e droni avanzati, mentre la Forza Marittima di Autodifesa giapponese continua a essere una delle più moderne al mondo (con cacciatorpediniere Aegis all’avanguardia, sottomarini diesel-elettrici sofisticati e due portaelicotteri portaerei leggere che verranno equipaggiate con caccia F-35B a decollo corto). Pur non disponendo dell’arsenale nucleare né della profondità di risorse della controparte cinese, il Giappone sta quindi riscoprendo una postura militare più assertiva, rafforzando al contempo la cooperazione con gli alleati regionali e soprattutto con gli Stati Uniti per bilanciare la potenza cinese.
Simulazioni di guerra e scenari possibili
Un conflitto armato diretto tra Cina e Giappone rimane per ora un’ipotesi estrema, ma non del tutto inconcepibile alla luce delle tensioni crescenti. Gli analisti individuano principalmente due scenari potenziali di scontro: uno legato a crisi locali circoscritte (ad esempio un incidente o un’escalation nel Mar Cinese Orientale attorno alle isole Senkaku/Diaoyu) e uno di portata più ampia legato a Taiwan. Proprio quest’ultimo viene considerato lo scenario più pericoloso e plausibile, dato il coinvolgimento di interessi vitali per entrambe le potenze. Non a caso, nel novembre 2025 la situazione si è improvvisamente surriscaldata sul fronte taiwanese: il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha avvertito pubblicamente che un eventuale intervento militare giapponese a favore di Taiwan in caso di crisi nello Stretto verrebbe considerato da Pechino alla stregua di un “atto di invasione” e provocherebbe una “forte reazione” da parte cinese. Questo monito è giunto in risposta a dichiarazioni della neo-premier giapponese Sanae Takaichi, che pochi giorni prima aveva affermato dinanzi al Parlamento come un attacco cinese a Taiwan costituirebbe per il Giappone una “situazione che minaccia la sopravvivenza” nazionale, concetto che – in base alle leggi sulla sicurezza di Tokyo – aprirebbe la strada a un intervento armato nipponico in aiuto dell’isola. Tale scambio di avvertimenti ufficiali ha fatto impennare la tensione tra Pechino e Tokyo, dimostrando come la questione di Taiwan sia divenuta il nodo cruciale in grado di catalizzare uno scontro diretto tra le due potenze asiatiche.
Al di là della retorica infuocata, negli ultimi anni sono state condotte diverse simulazioni di guerra (wargame) per valutare gli esiti di un ipotetico conflitto nell’Indo-Pacifico che coinvolga Cina e Giappone, spesso inquadrato nel contesto di una guerra per Taiwan. Uno studio del centro di ricerca statunitense CSIS, basato su 24 wargame riguardanti un’invasione cinese di Taiwan nel prossimo futuro, suggerisce che in molti scenari le forze congiunte di Stati Uniti, Giappone e Taiwan riuscirebbero effettivamente a respingere un attacco della Cina, salvaguardando l’autonomia di Taipei – ma solo al prezzo di perdite estremamente elevate. Nelle simulazioni del CSIS, la coalizione difensiva subisce la distruzione di decine di navi da guerra e di centinaia di velivoli, nonché la morte di decine di migliaia di militari, anche nei casi di “vittoria” strategica degli alleati. La stessa Cina, pur riuscendo a infliggere gravi danni, pagherebbe un costo altissimo in termini di perdite umane e materiali, e il fallimento nell’occupare Taiwan potrebbe perfino destabilizzare la tenuta interna del regime di Pechino. In altri termini, qualsiasi conflitto su larga scala tra Cina e Giappone (inevitabilmente esteso anche agli Stati Uniti, legati a Tokyo da un trattato di sicurezza) avrebbe conseguenze catastrofiche per tutti i protagonisti, risultando in una devastazione reciproca senza vincitori chiari. Proprio la consapevolezza di questi rischi funge finora da deterrente fondamentale: nessuna delle parti, per quanto assertiva nelle proprie rivendicazioni, sembra realmente disposta a oltrepassare la soglia di un confronto militare diretto. Mantenere aperti i canali diplomatici e rafforzare le misure di de-escalation è cruciale per scongiurare che le attuali rivalità sfocino in un conflitto aperto dalle conseguenze incalcolabili.


